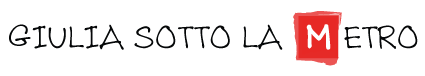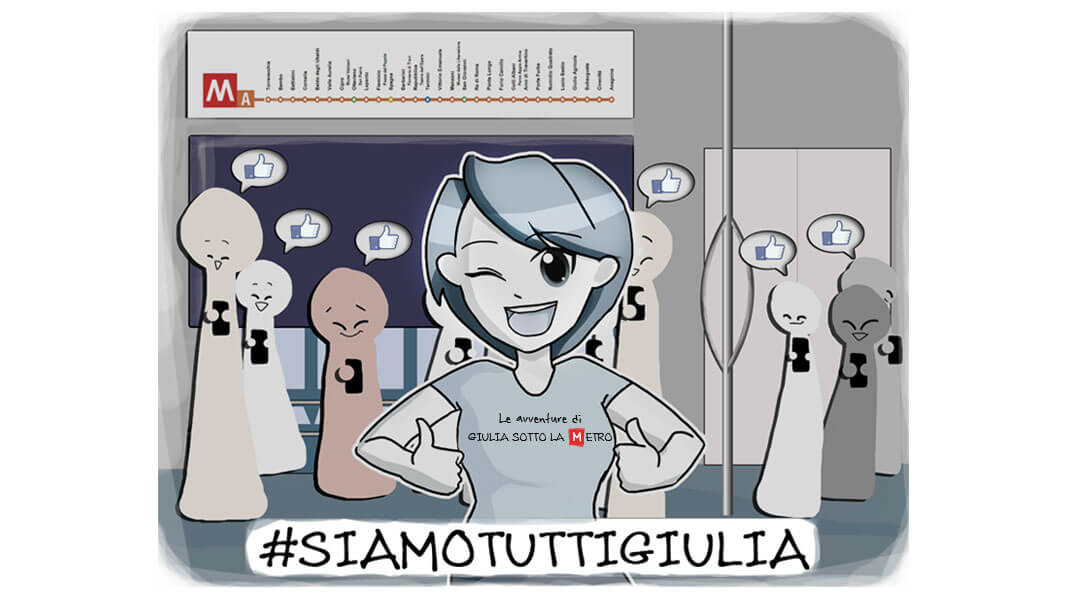E piove ancora.
E poi arriva la volta che rimpiangi di non aver preso la metro. Roba da non credere, eh? Eppure è così.
È un giorno di diluvio universale a Roma, di quelli che per prendere la metro devi portarti il canotto da casa perché i binari sono allagati e i viaggiatori si confondono tra anatre, pantegane e castori.
In redazione – proprio oggi, guarda caso – decidono che devo andare di corsa alla Biblioteca Nazionale per prendere un libro senza il quale – proprio oggi, ripeto – non si può portare avanti la scrittura del documentario che stiamo realizzando.
Provo a risparmiarmi l’incombenza, adducendo il classico campionario di scuse: nonni in fin di vita, urgenti telefonate da fare prima dell’imminente fine del mondo, le mitologiche cavallette di John Belushi.
Ovviamente, è tutto inutile.
Arraffo cappotto, galosce, ombrello e tutta la pazienza che riesco a trovare in giro per l’ufficio; dopodiché chiamo il taxi e vado ad aspettarlo in strada, nella speranza di non inzupparmi completamente ancora prima di partire.
A sorpresa, il tassista arriva entro i tre minuti promessi dall’operatrice telefonica:
“Ndo ’nnamo, signorì?”.
Avrei voluto dirgli “Buongiorno”, ma a questo punto passo direttamente alla risposta: “Biblioteca Nazionale, per favore.”
Ma sbaglio.
“Ah, là no. Nun ce potemo annà, signorì.”
“E perché?”
“Perché no.”
“La strada è allagata?”
“No, ma de che.”
“E allora perché non ci possiamo andare?”
Mi guarda e non favella.
Per un attimo temo che non capisca l’italiano e quindi provo con il romanesco stretto che – modestia a parte – parlo fluentemente al pari di altre quattro lingue (anzi, molto meglio. Anzi, forse lo dovrei mettere sul curriculum).
“Scusa, zi’: si la strada nun è allagata… scialla, no?”
“Eh no! Nun è scialla manco pe’ gnente!” (Vedi, ha funzionato! Allora continuo…).
“E magari me vói dì perché, zi’?”
“Perché la Biblioteca Nazionale sta a Castro Pretorio, signorì!”
“Embè?” (Avrei potuto dire di peggio, amici romani, e voi lo sapete bene).
“Embè, a Castro Pretorio ce vive la donna mia… che m’ha accannato ’na settimana fa, ’sta stronza!”
(Oh, finalmente ho capito perché da cinque minuti stiamo ancora fermi davanti alla mia redazione. Con il tassametro che gira, naturalmente!)
“Scusa zi’, io so’ sicura che è ’na stronza come dici te… ma magari manco sta a casa!”
“Po esse, ma a me nun me cambia un cazzo. Io come vedo er palazzo piango. Piango come ’na creatura, signorì… E mica me posso fa’ vede in servizio che piango come ’na creatura, lei che dice?”
(Vedi come piangi uguale, se non stacchi quel tassametro prima di subito!)
“No zi’… Te capisco e te l’appoggio. Ma nun potemo passa’ da ’n’artra parte? Magari famo er giro da dietro, magari me lasci prima. Scusa se insisto, zi’, ma si nun ce vado… a lavoro me se bevono sicuro!”
“Vabbè, signorì, m’ha convinto. Ce manca solo che se la pija ’n saccoccia pure lei… Je sta bene piazza Indipendenza?”
“Eddaje, va’… Basta che arivamo.”
Il fatto di averlo accontentato mi ha finalmente permesso di muovermi da piazza Cola di Rienzo, ma in cambio mi ha catapultato direttamente nel problema successivo. Questo:
“Eh… me scusi, signorì, si j’ho fatto perde tempo. Ma lei nun po capì che m’ha combinato ’sta stronza.”
No, in effetti in un primo momento non lo posso capire, ma ora che lui mi spiega tutto per filo e per segno, giuro che lo capisco benissimo (così come capisco benissimo che io non lo volevo assolutamente sapere).
Perché a quanto pare questi due stavano insieme da una vita, ma poi un bel giorno lui ha iniziato a vedere atteggiamenti strani, e poi ha scoperto che la tipa aveva un secondo cellulare segreto, e poi ha scoperto che aveva proprio tutta una vita segreta, e alla fine ha scoperto pure che in questa vita segreta c’era un amante.
Solo che l’amante era con l’apostrofo.
Era un’amante. Esatto, nel senso di una donna.
“Ha capito, signorì, com’è finita? Che si nun me mollava lei, l’anno prossimo a giugno me toccava annà a sfilà ar gay pride!”
Poveretto. Tutto sommato, l’ha presa anche troppo bene.
D’altronde, se avesse beccato la tipa con Brad Pitt avrebbe finito per suicidarsi dallo smacco.
Ma, parliamoci chiaro, la partita contro un’altra donna è persa in partenza.
Sei-zero sei-zero.
Impraticabilità di campo.
Waterloo, tipo.
E, visto che, da quando è finito il racconto, per l’imbarazzo non sono più riuscita a spiccicare parola, provo a esprimere a voce questo ultimo concetto. Non ci riesco, però, perché in realtà siamo arrivati – come promesso – a piazza Indipendenza.
Io vorrei solo scendere, correre a prendere il libro in biblioteca e tornare in redazione, possibilmente senza incappare nel nubifragio. E invece sto ancora dentro al taxi, incerta se consolare l’amico disperato o pagargli la corsa e darmela a gambe.
A proposito, quanto gli dovrò a ’sto gran paraculo dal cuore infranto e dal tassametro a ruota libera?
“Ma che me deve da’, signorì! Offre la casa!”
“Perché, zi’?”
“Perché io nun la volevo portà a destinazione e lei invece m’ha pure consolato… È stata troppo gentile, me permetta de sdebbitamme!”
E dopo dieci minuti trascorsi a prendere mentalmente per i fondelli l’amico bistrattato, ora mi sento veramente una merda. Vabbè che – calcolando la pioggia, il lavoro e la biblioteca – mi ci sentivo pure all’inizio della storia, quindi se inverto l’ordine dei fattori e il risultato non cambia, almeno io ci ho rimediato una corsa gratis.
(Tratto da una storia realmente accaduta ad Antonio C., lettore di “Giulia sotto la metro”.)