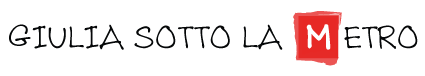Cara Giulia, ti devo assolutamente raccontare quello che mi è successo oggi.
Se ci sia stato uno sciopero, un incidente, una invasione zombie o semplicemente due gocce d’acqua, non te lo so dire; sta di fatto, però, che il 14 era una scatoletta di tonno e la gente aveva i segni delle porte a soffietto in faccia.
Pressato contro la porta anteriore, ascoltavo per forza di cose una signora assai distinta ed impellicciata che, in un forbito italiano con evidente accento del nord, declamava al telefono i disagi di Roma pronunciando una B talmente lieve da sembrare una V, come i giapponesi.
“Ma guàvda, ti dico… cvuésta città è incvuedìvile! Tesòòvo, cvuì fàno due gocce d’acvua e guavda… Un maccélo che non ti dico, amòve… Ma sì, cèvto che non vedo l’òva di vivedévti… Dai facciamo un apevitìvo con la Gina, la Pina e la Tina (e la Santa Maria, no?) Che ne diciui?”
Insomma,una filippica forbita e accentata ad accompagnare il viaggio a passo d’uomo sciancato verso casa. Ad un certo punto, però, ecco il casus belli, o meglio: er fattaccio!
Il conducente, nonostante je se stia per bombare la vettura pe’ quanta gente c’è dentro, decide di fermarsi alla fermata successiva e di tentare le manovre di fuoriuscita passeggeri con la classica tiritera: “Fate un passo indietro!”
E la gente gli fa subito eco: “Dai, che ce la facciamo: al centro è vuoto!”
Oppure: “Signora, anche io ho diritto di salire come lei!”
O ancora: “Si te levi dalla porta, po’ esse che salgo pure io!” (And so on.)
Insomma, tutto il repertorio della disperazione, la rabbia e l’incapacità di andare oltre il proprio naso tipiche di noi romani, che notoriamente diamo il meglio di noi stessi di fronte ad un tram strapieno all’inverosimile, dopo chissà quanto tempo di attesa.
Noi al sicuro a bordo difendiamo a spada tratta il nostro diritto a scambiarci cellule morte e coibentarci tra sconosciuti adesi.
“A signò, ma ‘ndo vò annà?!”
“Aspetti che monto a cavacecio a ‘sto vecchietto, così lei entra!” (And so on.)
In tutto questo, la signora distinta alle mie spalle si produce in una telecronaca telefonica di quanto sta accadendo: “Ecco, tesòvo… Ova siamo févmi vloccàti ad una févmata pevché la giuénte inzivile (pure la Z al posto della C, nient’altro?) non capissiue che non z’è altro posto a bòvdo, ma guààvda te, una voba…”
Il suo distaccato e algido racconto, però, si blocca a causa del sopraggiungere dell’oriunda germanica, secca e tosta come una imprecazione aspirata, incattivita da una città che – rispetto ai suoi standard aviti – non dovrebbe proprio essere catalogata come città.
Rimasta ultima tra quelli che volevano salire (in Germania, evidentemente, il gomito è solo una banale articolazione del braccio), riesce a mettere giusto la punta dei piedi sul primo scalino ed aggrapparsi al corrimano verticale, lasciando però per forza di cose il resto del corpo fuori dal mezzo.
Poveretta, lei ci prova pure a lottare per il suo posto al sole:
“Fate pazzettino, tài che enthriàmo!”
“Al shentro ezzere fuòto! Anche io afére tiritto ti zalire!” (And so on.)
Ahimé, però, i romani non subiscono il fascino dell’accento burgundo.
“Seee… A bella! Ma ndo voi annà!”
“Seee… mo ariva questa daa foresta nera! Varo! Rendimi le mie Legioni!” (And so on.)
C’è da dire, a discolpa del popolo romano, che di suo la vichinga non si impegna certo per avere il Nobel per la pace: “Se non mi fate salire io non fi faccio partire! Rimanko kvì e non mi muòfo!”
Urla, bestemmie, suoni di buccine che richiamano a raccolta i manipoli sotto ai signa, persino il conducente che si indigna col tipico tono professionale dei conducenti romani:
“Aho, si nun me fai partì chiamo li Carabbbiggnèri!”
Ma nulla: la teutonica è lì, ferma come un sol’uomo. Anzi, una sola donna.
Nel delirio, all’improvviso, un’esclamazione d’ira senza uguali: “Uè, figli’e zoccola! I t’accire, capit’? T’accire! Oggi aggia passà n’uaie!”
L’esclamazione partenopea fa da colonna sonora all’azione di una feroce mano artigliata che tenta di cavare gli occhi della teutonica.
Una mano collegata ad un braccio impellicciato.
Una pelliccia tipica di coloro che parlano con la erre moscia e con la z al posto della c.
È lei… la contessa al telefono!
La teutonica, seriamente minacciata, molla la presa e rimane ansimante sul marciapiede a inveire in antico cimbro. Dal canto suo, la contessa riprende la conversazione telefonica e, come in un mito di Esopo, recita la morale della favola: “A’ e verè sta zoccola: nge vuliv’ fa’ partì, ‘sta fij’e’ndrocchia! Ci aggia miss’ a mano n’faccia a ‘sta janara, puozz’ passa’ nu uaje ‘a notte ‘e Natale…”
Eccole qua, le vedi?
Sono le meraviglie di Roma, città multietnica, multilingue e pure un pò bipolare.
A trovarne, di metropoli così… vero, Giulia?
A presto,
Luisa
Cara Luisa, leggendo il tuo racconto oltre a ridere di gusto e ad apprezzare la tua capacità di rendere onore agli eventi in corso, ho capito una cosa fondamentale.
L’abito non fa il monaco… Non giudicare un libro dalla copertina… La morte non è mai così brutta come la si dipinge. Ecco, queste non sono frasi campate in aria e senza un vero perché che i nostri genitori ci raccontano per confonderci le idee durante l’infanzia. In realtà, sono preziosissimi consigli per imparare a capire che il nostro vicino sui mezzi pubblici è sempre pronto a stupirci da un momento all’altro. Anche quando non lo diremmo mai e poi mai.
Perciò grazie di cuore da parte mia,
Giulia sotto la metro