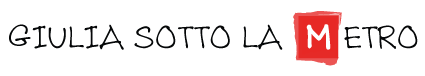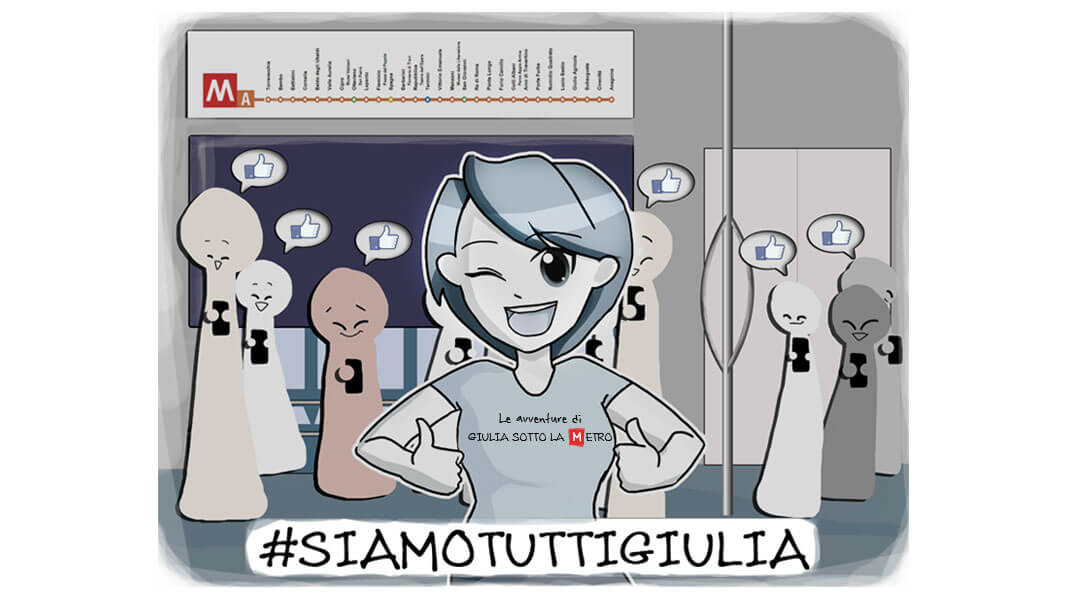Ormai il concetto è chiaro: quando c’è sciopero e io prendo l’autobus, so’ cazzi. I maligni potrebbero insinuare che porto scarogna, i raziocinanti osserverebbero che le condizioni di caos in cui versa la città in quei giorni favoriscono la nascita di determinate situazioni. Io asserisco semplicemente che certe cose me le eviterei volentieri, ma che ci posso fare… a lavorare ce devo annà, mica me lo pagate voi lo stipendio!
Dopo una giornata di lavoro ricca – e come ti sbagli? – di stress, tranelli e cazziatoni, mi ritrovo a bordo di un 360 che procede a passo d’uomo, con la vana speranza di arrivare in palestra prima che finisca l’orario di allenamento.
(Me viè da ride. Co’ sta velocità media, grasso che cola se arrivo a casa mia prima dell’alba.)
Dopo Termini, l’autobus inizia a svuotarsi quel tanto che basta per poter stimare il numero dei soggetti a bordo. Nella parte posteriore dell’autobus scorgo due ragazzi: uno è africano, di probabile provenienza somala, ed è vestito con abiti sgargianti al limite del pessimo gusto; l’altro invece è latino, probabilmente colombiano, e ha una bandana sulla fronte che la metà basta.
Dato che si esprimono prevalentemente nelle proprie lingue e solo con degli sporadici inserti in italiano, non saprei dirvi perché all’improvviso abbiano iniziato a litigare violentemente. Gli insulti e gli spintoni, però, ve li posso raccontare senza problemi, intervallati di tanto in tanto anche dall’intercalare: “Oh regà, reggeteme, ché io a questo lo gonfio”.
(In italiano, sì. Lo sanno dire entrambi correttamente. Ci sarà un motivo, suppongo.)
La pantomima va avanti per un po’ senza colpi di scena. La gente a bordo, però, inizia a sentire un forte bisogno di partecipare: mormorii, cenni di dissenso, movimenti furtivi qua e là… L’atmosfera inizia a scaldarsi e, d’altronde, è sempre così che va a finire.
Dopo uno spintone più forte degli altri, un secondo africano si alza da uno dei sedili vicini. Vestiti più sobri, ma capelli verdi. (Devo aggiungere altro?)
Si schiera accanto al compatriota, con il chiaro atteggiamento di chi vuole dare man forte.
Così siamo due contro uno e ci vuole poco perché i toni si alzino di brutto e definitivamente: gli insulti si fanno del tutto comprensibili e gli spintoni iniziano a raggiungere anche i passeggeri vicini, come le tre signore (anche loro latine) sedute nella fila davanti agli energumeni, che a un certo punto iniziano a chiedere aiuto, come se fino a dieci secondi prima non fosse accaduto un bel niente.
Sembrano un po’ fuori di zucca, in effetti, e non solo per i gridolini stile pollaio, ma anche per l’abbigliamento folcloristico a base di giallo acceso e viola fluo, per le acconciature spaziali che sfidano la forza di gravità e per le unghie laccate che Florence Griffith negli anni ’80 al confronto non era nessuno.
Sono terrorizzate, ve lo giuro. Non sapete quanto si stiano agitando e tutto ciò è divertentissimo, perché l’ultima volta che le ho guardate se ne stavano beatamente a chiacchierare tra loro, sbocconcellando dolciumi da un sacchetto.
Un altro spintone africano, un altro insulto in spagnolo ed ecco che le signore si alzano di scatto tutte e tre insieme, si avventano sul pulsante per prenotare la fermata e cercano di raggiungere la porta.
La loro placida serenità di pochi attimi prima è stata ormai sostituita da quel sano terrore, che solo ai protagonisti di Cloverfield si leggeva negli occhi. La sorte, però, non accenna a dimostrarsi benevola: nel momento stesso in cui accede a piazza San Giovanni, l’autobus si pianta.
Brutto rumore, sbuffo di fumo, motore kaputt.
E ora? Ci chiediamo un po’ tutti, tranne ovviamente i tre litiganti etnici che continuano a minacciarsi come se non ci fosse un domani. Dal registro stilistico delle loro parole, si intuisce che gli manca poco alla cosiddetta tracca finale.
Africano n.1 si avvia verso la porta dell’autobus e urla: “Scendi, ché ti gonfio!”.
A quella minaccia in romanesco, Columbia neanche risponde, occupato com’è a divincolarsi dalla stretta di Africano n.2, noto anche come Capelli Verdi o ancora meglio come Capelli di Alghe (sì, esatto: come la tipa di Hello Spank).
Mentre nel frattempo l’autobus non accenna a ripartire, lo scenario si fa più interessante: Africano n.1 è uscito fuori e inveisce sbattendo i pugni contro il vetro del finestrino, ma Capelli di Alghe e Columbia sono rimasti a bordo. All’inizio c’era baruffa tra loro, ma ora non più. Anzi.
Se ci pensate, tutto ciò è molto surreale. Voglio dire: mi trovo bloccata in mezzo a Piazza San Giovanni su un autobus rotto che nessuno accenna riparare; fuori c’è un africano impazzito che manda maledizioni in lingue ignote, dentro invece ci sono un colombiano e un secondo africano dai capelli verdi che – nel giro di cinque minuti – sono passati dal volersi ammazzare all’essere quasi diventati amici.
(Per di più, l’uno non accenna a risalire a bordo, gli altri a scendere in strada. Ergo, come diceva l’onorevole Bersani qualche anno fa: “Ma di cosa stiam discutendo?”)
L’ineluttabile drammaticità della scena è evidente a tutti.
Africano n.1 rimarrà per sempre a sbattere i pugni contro il finestrino? Capelli di Alghe e Columbia scapperanno insieme, lasciando Africano n.1 da solo come uno scemo? Oppure è tutta una tattica per far rilassare Columbia e permettere a Capelli di Alghe di consegnarlo inerme ad Africano n.1? O magari finirà tutto a tarallucci e vino e i tre se ne andranno, ubriachi e felici, insieme verso il tramonto?
Vorrei tanto poter dare una risposta a questo interrogativo, ve lo giuro. Lo vorrei tanto, ma non posso. Perché quando l’autista ha iniziato a spiegare che il guasto al motore era più serio del previsto, che avremmo dovuto attendere almeno un’ora prima dell’arrivo dei soccorsi e che sarebbe stato meglio prendere in considerazione percorsi alternativi… beh, sapete com’è, non ci ho pensato su due volte.
Sono scesa dall’autobus e ho iniziato a camminare lungo via Appia, mentre le parolacce di Africano n. 1 si trasformavano in un’eco sempre più lontana alle mie spalle.
(Tratto da una storia realmente accaduta a Carlo S., lettore di “Giulia sotto la metro”)