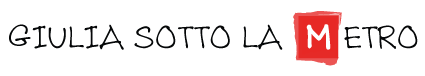Se fosse sogno o realtà non lo saprò mai, ma il fatto è che nel mezzo del cammin della mia vita mi sono ritrovata per una selva oscura… Vabbè, mo’, oscura proprio no, dài; forse non era tenuta benissimo – come spesso accade ai posti belli di Roma – ma era sicuramente un parco strano. Molto strano. Sembrava la Caffarella, ma non era la Caffarella. Sembrava Villa Ada, ma non era Villa Ada.
Osservando più da vicino la scena – attraverso quella macchina da presa senziente che solo i sogni sanno fornire – mi rendevo conto che la mia esplorazione del luogo misterioso non avveniva a piedi, ma (…e come te sbaji? Manco nei sogni me lasciano ‘n pace!) a bordo di un buffo trenino senza nome né numero. Un espresso di Hogwarts de noantri che attraversava tutto il parco lungo un tracciato ben preciso.
I viottoli di questa oasi verde un po’ decadente e allo stesso tempo stranamente familiare, ospitavano varie casette a due piani, tutte abitate. Erano una dozzina, sparse qua e là, ma mai troppo lontane le une dalle altre e tutte – lo capivo benissimo, anche se non avrei saputo dire perché – abitate da sempre dalle stesse persone.
Il trenino si fermava davanti a ogni porta, emetteva un suono tutto speciale, più simile a quello di un orologio a cucù, e avvisava gli abitanti che era ora di andare a lavoro. Mi sentivo un po’ intrusa e un po’ ospite d’onore su quella vettura da fiaba, mentre vedevo salire a bordo uno a uno gli abitanti di quelle casette, che si salutavano come chi si conosce da sempre e da sempre compie gli stessi gesti. (Una versione meno hollywoodiana di Truman show, praticamente.)
Ho visto salire un anziano professore che elargiva libri a tutti coloro che ci raggiungevano a bordo del trenino; una prosperosa madre di famiglia partenopea che distribuiva con entusiasmo pastiera e sartù, anche a me che non c’entravo nulla; un ragazzo che (anche se non me lo aveva detto nessuno, era ovvio che fosse così) si era appena trasferito nel parco e aveva difficoltà a capire gli orari delle fermate del trenino, e poi un suo amico dall’aria sfigatissima, la cui timidezza gli impediva di rivolgere parola a qualsiasi essere di sesso femminile, coccinelle e lucertole comprese.
L’ultima a salire bordo è stata una ragazza sfortunatissima alla quale era stata portata via la macchina all’improvviso e che perciò rischiava di arrivare tardi a un colloquio di lavoro. L’unico modo che aveva trovato per tentare comunque di andarci era prendere al volo il trenino, anche se tutti quanti sapevamo che il posto in cui doveva andare non era sul nostro percorso. (E bravi, tutti a preoccuparsi per la tipa, tutti a fare le facce tristi per il suo colloquio inevitabilmente mancato, ma provare ad avvertirla, no, eh? Tutti a farsi i cazzi propri coi libri del professore e la pastiera della signora napoletana e nessuno che le consigliasse di scendere e provare altrove… Belle merde, i passeggeri del trasporto pubblico. Pure nei sogni, che cavolo!)
Sarà stato forse per colpa di questo menefreghismo ingiustificato, o forse per colpa della sfiga endemica che colpisce ogni tipo di mezzo, sta di fatto che all’improvviso intorno a me è cambiato tutto. Con quella leggera inquietudine che assale quando non ci si sente totalmente padroni di una situazione, ho iniziato a notare che, uscito dall’insolito parco, il trenino stava saltando tutte le fermate.
Guardandomi intorno alla ricerca di una spiegazione, mi sono resa conto con orrore del fatto che le persone intorno a me non erano le stesse. Niente più libri, niente più pastiera, ma solo una folla di spettrali passeggeri senza volto, conducente compreso (e questa poteva anche essere una buona notizia, data la faccia da c**o che a volte hanno certi dipendenti Atac. Sul momento, però, non ho saputo cogliere la sottigliezza. Vogliate perdonarmi, sono una che si impressiona facilmente: ero circondata da una folla di anime prive di occhi, naso, bocca e orecchie. Una miriade di teste d’uovo, se vogliamo).
Erano tante le azioni che avrei potuto compiere per sottrarmi a quella situazione di angoscia, ma non ho trovato niente di meglio che urlare: “Qualcuno sa dirmi dove ferma questo maledetto treno?”
(Già. Come se qualcuno tra quegli strani esseri avesse potuto rispondermi. Non avevano la bocca, maledizione!)
L’ansia galoppava dentro di me, piazzata come un macigno all’altezza del mio sterno, e cresceva al diminuire delle mie possibilità di fuga. Rimpiangevo la metro A, giuravo che se solo fossi riuscita ad arrivare a casa (o anche solo in ufficio, a Ottaviano) non avrei mai più detto niente di male, né scritto una riga di prese per il culo. Volevo solo scendere; ed era bizzarro, perché in genere a stento riesco a salire a bordo. Se solo qualcuno avesse potuto spiegarmi cosa diavolo stava succedendo…
La risposta è arrivata all’improvviso, guardando la mia immagine riflessa in un finestrino del treno: i miei capelli non erano più ramati, ma neri; la mia giacca bianca era diventata nera, la mia camicia blu ora era rossa. E accanto a me, con aria sardonica, è comparso un ometto con i baffoni e gli occhiali. “Prossima fermata, Inferi” diceva la voce metallica all’altoparlante. “Uscita lato… sinistro.”