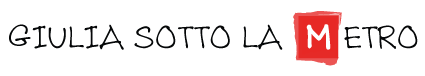Allora, la scena è sempre la stessa: ore 9:15, Furio Camillo, sonno.
La voglia di andare a lavorare è poca, ma – ahimè – l’impulso automatico che mi costringe a scendere le scale della stazione metropolitana funziona a prescindere dalla mia volontà. Così, faccio per mettere un piede sul primo gradino, quando mi accorgo che il cancello della fermata è sprangato.
Oddio: non c’è sciopero, non c’è polizia, non c’è l’alluvione stagionale… perché accidenti è chiuso?
La mia decennale esperienza di viaggiatrice metropolitana mi rende conscia da subito che a questo inquietante interrogativo (così come a tanti altri che riguardano il malfunzionamento del trasporto pubblico) non avrò facile risposta. E come in un flash improvviso, nella mia mente iniziano a risuonare parole. Parole forti, attraverso le quali spronare il popolo metropolitano a ribellarsi contro simili inspiegabili disagi:
“Oggi sono felice di essere con voi, in quella che nella storia sarà ricordata come la più grande manifestazione per la dignità del trasporto pubblico della nostra capitale!
Sessanta anni fa, grandi cittadini romani – i cui nomi si persero fra le pieghe della memoria, ma che ancora oggi gettano su di noi l’ombra simbolica del loro atto pionieristico – posero la prima pietra del sistema di trasporto pubblico sotterraneo, dando vita alle lunghe gallerie dell’emancipazione motoria dell’Urbe.
Si trattava di un evento epocale, che accese un grande faro di speranza per milioni di pedoni, marchiati dal fuoco di una bruciante ingiustizia:
non poter andare a lavorare in macchina.
Quella prima pietra giunse come un’aurora di gioia, e metteva fine alla lunga notte della loro cattività pedestre. Ma oggi – sono passati sessant’anni – i pedoni non sono liberi: sono ancora paralizzati dai tornelli della segregazione e dai binari della discriminazione sotterranea; vivono in un’isola solitaria di povertà, in mezzo a un immenso oceano di benessere materiale a quattro ruote; ancora languiscono negli angoli dei percorsi sotterranei, si ritrovano esuli, confinati a pochi metri sotto la propria terra.
Quindi oggi siamo venuti qui per tratteggiare a tinte forti una situazione vergognosa.
In un certo senso, siamo venuti nella capitale del nostro paese per incassare un assegno… dall’ATAC!”
(L’impeto della mia arringa mentale si placa per un attimo. Da un lato, mi guardo intorno per cercare di capire se stamattina potrò andare a lavorare in metropolitana, o se invece mi tocca andare a prendere l’87. Dall’altra, non posso fare a meno di chiedermi come mai quelle parole – che tanto spontaneamente stanno sgorgando dentro di me – mi suonino molto familiari.)
“Quando gli architetti della nostra rete di trasporto pubblico hanno scritto le magnifiche parole della Dichiarazione d’indipendenza del Viaggiatore Metropolitano, hanno firmato un “pagherò” di cui ciascun romano era destinato a ereditare la titolarità. Conteneva la promessa che a tutti gli uomini, agli appiedati come agli automobilisti, sarebbero stati garantiti questi diritti inalienabili: vita, libertà e una metro funzionante con un convoglio ogni due minuti.
Oggi appare evidente che Roma ha mancato di onorare il suo impegno debitorio.
Invece di adempiere a questo sacro dovere, Roma ha dato al popolo metropolitano un abbonamento (mensile o annuale, fate voi) a vuoto, una tesserina magnetica che è tornata indietro, con la scritta ‘copertura insufficiente’. Ma noi ci rifiutiamo di credere che i rivenditori autorizzati del trasporto urbano siano in fallimento. Ci rifiutiamo di credere che nei grandi caveau delle opportunità motorie di questo paese non vi siano fondi sufficienti per attrezzare un trasporto pubblico che funzioni ogni giorno.
E quindi siamo venuti a incassarlo, questo assegno: l’assegno che offre, a chi le richiede, la libertà di arrivare a lavoro in orario e la garanzia di poter salire su un vagone nel momento in cui ne ha bisogno.
Siamo venuti in questo luogo consacrato – la fermata di Furio Camillo, via Appia, angolo via Cesare Baronio – anche per ricordare all’Urbe l’infuocata urgenza dell’oggi.
Quest’ora non è fatta per il lusso di prendersela calma, seduti in un taxi, o di assumere la droga tranquillante del gradualismo, ché tanto c’ho la macchina, male che va la lascio sulle strisce.
Adesso è il momento di risollevarci dalla valle buia e desolata della segregazione a quattro ruote, fino al sentiero soleggiato della giustizia razziale per chi quelle quattro ruote non ce le ha, o non vuole spendere otto euro al giorno di grattino… ché tanto poi ti fanno la multa lo stesso.
Adesso è il momento di sollevare la nostra nazione dalle sabbie mobili dello sciopero sempre in agguato, per collocarla sulla roccia compatta del principio che
se vieni a lavoro tu, poi ci posso andare pure io.
Adesso è il momento di tradurre la giustizia in una realtà per tutti i figli di dio, degli abbonati come dei viaggiatori occasionali, della gente di Ottaviano come di quella di Anagnina.
Se la città eterna non cogliesse l’urgenza del presente, le conseguenze sarebbero funeste – ovvero, so’ cazzi.”
(Facendo il giro della fermata, mi sono resa conto che l’altro cancello è aperto: la gente sta scendendo verso la metropolitana che, in effetti, funziona regolarmente. In tutta sincerità, mi sento un po’ stupida, ma l’impeto del mio discorso mentale mi ha talmente fomentato che proseguo nella sua composizione, mentre – come ogni normalissimo giorno – passo la mia tessera al tornello.
Ciò nonostante, il dubbio: perché queste parole continuano a sembrarmi così familiari?)
“L’afosa estate della legittima insoddisfazione degli abbonati ATAC non finirà, fino a quando non saremo entrati nel frizzante autunno della libertà e dell’uguaglianza. Questo 2016 non è una fine, è un principio. A Roma non ci sarà né riposo né pace, finché i viaggiatori metropolitani non vedranno garantiti i loro diritti di contribuenti, finché non sorgerà il giorno luminoso della giustizia.
Ma c’è qualcosa che devo dire al mio popolo, fermo su una banchina rischiosa, alle porte di Furio Camillo (uscita lato destro): durante il processo che ci porterà a ottenere il posto a sedere che ci spetta di diritto, non dobbiamo commettere torti d’inciviltà. Dobbiamo sempre condurre la nostra lotta su un piano elevato di dignità e disciplina. Non dobbiamo permettere che la nostra protesta pedestre degeneri in violenza fisica (e/o verbale).
Sempre, e ancora e ancora, dobbiamo innalzarci fino alle vette maestose ove la forza fisica di Subaugusta s’incontra con la forza dell’anima di Cipro.
C’è chi domanda agli infervorati cittadini capitolini: ‘Quando sarete soddisfatti?’.
Non potremo mai essere soddisfatti, finché continueremo a subire gli indescrivibili orrori della calca nell’ora di punta, finché non riusciremo a trovare posto a sedere (e a volte anche in piedi), per dare riposo al nostro corpo affaticato dal viaggio, finché tutta la facoltà di movimento nei convogli resterà limitata alla possibilità di trasferirsi da un vagone affollato a uno altrettanto affollato, finché continueremo a fare lo slalom tra cartelli su cui sta scritto ‘Una moneta per mangiare’, finché chi viene da Cinecittà non avrà la certezza di poter raggiungere Ottaviano e chi viene da Ottaviano crederà di non avere la motivazione per affrontare un viaggio fino a Cinecittà.
No, no, non siamo soddisfatti e non saremo mai soddisfatti, finché il flusso dei convogli non scorrerà come l’acqua, e la linea A come un fiume in piena.”
(Via via che il mio discorso prende forma, scendo lungo la scala mobile e arrivo sulla banchina. Mi metto pazientemente in attesa della metro che mi porterà in Prati, assieme a tutti quelli che – come me – hanno capito che la metro non è sprangata del tutto.
Tutto regolare.
Se solo capissi cosa mi ricordano le parole che sto mettendo in fila con tanto fervore…)
“Io non dimentico che alcuni di voi sono venuti qui a Furio Camillo, dopo grandi prove e tribolazioni. Alcuni di voi hanno lasciato da poco vagoni angusti come celle di prigione. Alcuni di voi sono venuti da zone colpite dalle tempeste dell’isteria del romano medio sotto stress, travolte dai venti della brutalità poliziesca a caccia di rom e sedicenti terroristi. Siete i reduci della sofferenza itinerante a fermate.
Continuate il vostro viaggio, nella fede che la sofferenza immeritata ha per frutto la redenzione.
Tornate a Repubblica, tornate a Numidio Quadrato, tornate a Ponte Lungo, tornate a Flaminio, tornate ai vostri uffici in centro o ai vostri appartamenti in periferia, sapendo che in qualche modo questa situazione può cambiare e cambierà. Non indugiamo nella valle della disperazione.
Oggi, amici miei, vi dico: anche se dobbiamo affrontare le difficoltà di oggi e di domani, io continuo ad avere un sogno. Io ho un sogno, che ha radici profonde nel sogno capitolino.
(E mentre all’improvviso la mia mente viene inondata dalle immagini di una folla oceanica, radunata in quel di Washington il 28 agosto 1963 – e finalmente mi è chiaro da dove vengano le mie parole – io vedo il mio sogno avverarsi: vedo arrivare un convoglio interamente vuoto.
Cammina piano, come un immenso e assonnato centipede, e si accosta alla banchina più lentamente del solito. C’è tempo per salire, c’è spazio per sedersi: è il sogno di un viaggio senza disagi che tutti inseguiamo coraggiosamente e invano ogni mattina. Invano, fino a oggi.)
Ho un sogno: che un giorno questa città risorgerà e vivrà il significato vero della parola metropolitana.
Oggi ho un sogno: che un giorno sulla Piazza di San Giovanni i figli della metro A e i figli della metro B potranno sedersi insieme alla stessa tavola dei figli della metro C.
Ho un sogno: che un giorno perfino la fermata di Rebibbia – dove si patisce il caldo afoso dell’ingiustizia, il caldo afoso dell’oppressione – si trasformerà in un’oasi di libertà e di giustizia.
Oggi ho un sogno.
Ho un sogno: che un giorno ogni buca sarà coperta, ogni sampietrino limato, i luoghi sterrati diventeranno asfaltati, e le strade sconnesse diventeranno diritte, e la gloria del Signore sarà rivelata, e tutte le creature (sub)urbane la vedranno insieme.
Questa è la fede che porterò con me, tornando stasera da Ottaviano a Roma Sud.
Con questa fede potremo cavare dal Colle Capitolino della disperazione una pietra di speranza per la fermata di Piazza Venezia. Potremo andare a lavorare insieme, andare a pregare insieme, andare a manifestare insieme, andare in prigione insieme, schierarci insieme per la libertà del trasporto pubblico, sapendo che un giorno saremo liberi (di andare dove cazzo ci pare, o quasi).
Quel giorno verrà. Quel giorno verrà, quando tutti i figli di dio potranno cantare con un significato nuovo: ‘Fatece largo che passamo noi / li giovanotti de ‘sta Roma bella. / Semo ragazzi fatti cor pennello / e le ragazze famo innamorà’.
(Il sogno si sta realizzando davanti agli occhi increduli miei e di chi è con me sotto la metro, in questa afosa mattina romana. Il convoglio si ferma. Noi attendiamo con emozione l’apertura delle porte. Un istante, due, tre… La magia dell’attesa si insinua tra i viaggiatori, travestita da ansia sottile. Qualcuno, timoroso, protende il dito indice fino a spingere il pulsante verde al centro della porta scorrevole, anche se – come tutti sanno, sin dal giorno che quei pulsati sono stati installati – è un gesto che non serve a un beneamato cazzo.
Le porte, infatti, non si aprono. Noi tratteniamo il fiato e attendiamo ancora. All’improvviso, però, le luci all’interno dei vagoni si spengono, si ode il caratteristico sbuffo che precede sempre una ripartenza e dopo un istante il convoglio riparte.
Destinazione deposito, come compare scritto sui led luminosi in testa e in coda.
Rimaniamo tutti lì come una massa di cretini, con quel sogno che avevamo realizzato e che ora giace in frantumi tra i binari e la monnezza accumulata dalle cinque di stamattina.
Ma non importa: noi viaggiatori metropolitani siamo abituati alla delusione e non perdiamo le forze per rincorrere un’utopia che – proprio come il buon vecchio Martin Luther, ne siamo certi – prima o poi diventerà realtà.)
E dunque, che la libertà del trasporto metropolitano riecheggi sui sette colli attorno a Cavour e sui Colli Albani dopo Anagnina, sulla scalinata di Trinità dei Monti a Spagna e sulla Scala Santa di San Giovanni, sui verdi prati di Eur Fermi e anche su quelli di Eur Palasport. Ma non soltanto.
Che la libertà riecheggi da ogni tornello, da ogni binario, da ogni banchina, da ogni fermata, che da ogni obliteratrice riecheggi la libertà. E quando questo avverrà, saremo riusciti ad avvicinare quel giorno in cui tutti i figli di Dio, pedoni e automobilisti, laziali e romanisti, coatti e pariolini, potranno prendersi per mano e cantare le parole dell’antico inno:
“Portace ’n’artro litro / ché noi se lo bevemo / e poi j’arisponnemo: / Embè, embè, che c’è?”.