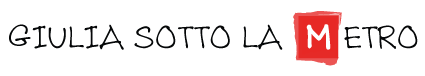C’è stato un tempo (lontano quanto meraviglioso) in cui abitavo a Parigi. È anche lì mi spostavo quotidianamente in metro.
All’epoca, nel 2002, Parigi era un luogo sicuro, un luogo in cui non dovevi aver paura di andare a sentire un concerto degli Eagles of Death Metal, di andare a vedere una partita della nazionale o persino di andare a cena dal cambogiano. Era un tempo in cui, nonostante l’11 settembre fosse ancora giusto dietro l’angolo, e nonostante io lavorassi nel posto probabilmente più affollato di tutto il circondario, i miei superiori continuavano a ripetere: “Nun te preoccupà, qua a a Disney er cuggino de Bin Laden è azzionista de maggioranza… qua nessuno ce torce ‘n capello!” (Vabbè, ovviamente loro lo dicevano in dialetto parigino delle banlieue… ma in effetti, mutatis mutandis, non è che poi suoni così dissimile dal dialetto romano, sa’?)
Era un tempo in cui si poteva andare dappertutto senza problemi, di mattina, di pomeriggio e di notte. Anche da soli, davvero.
Era un tempo in cui c’era solo un posto che bisognava temere come la peste, un posto che, a passarci dopo mezzanotte, diventava pericoloso come un Gremlin che avesse appena mangiato un Big Mac.
Sto parlando della stazione della metropolitana di Les Halles.
Sto parlando di un coacervo di binari e livelli sovrapposti, di ascensori e di venditori ambulanti, di siringhe a terra e poliziotti in borghese, di loschi figuri minacciosi, fungo cruento, cupola e gran fumata (cit. Neruda, per la precisione.)
Sto parlando di un posto in cui, Dio non voglia, se ti toccava chiamare aiuto, quasi pregavi che non rispondesse nessuno… perché forse quello che ti rispondeva era anche peggio di quello che ti attaccava.
A volte, però, di notte a Les Halles da sola ci sono dovuta passare.
E questa è la volta in cui, a conti fatti, mi è andata peggio.
Notte fredda, notte da lupi, nonostante le luminarie natalizie che già da qualche tempo illuminano a giorno la Ville Lumière.
Mi avvio a passo spedito verso il mio binario perché l’ultimo treno che torna a Marne la Vallée, ovvero a casa da Topolino, sta per partire. Non lo posso perdere, perché poi mi toccherebbe dormire là sotto con i barboni e i criminali e, tutto sommato, non mi sento ancora pronta per un’esperienza del genere.
Per fortuna, la mia corsa è servita perché quando arrivo a sedermi all’interno del vagone mancano ancora alcuni minuti alla partenza. Insieme a me — e come ti sbagli? — ci saranno sì e no dieci persone, due delle quali mi stanno già facendo pentire di essere salita a bordo.
Lei è minuta, nerissima, con milioni di treccine in testa e di monili d’oro al collo.
Lui è enorme, ancora più nero di lei, agghindato come un rapper di Detroit e mortacci suoi come strilla.
Io non vivo a Parigi da molto, ho ancora qualche problema di comprendonio, soprattutto quando le persone parlano veloci, a voce alta e in slang molto stretto. Ovvero, come questo tipo qua.
Quindi, di fatto, non colgo proprio tutto tutto… Ma una cosa l’ho capita: per quanto lei possa negare, lui è sicuro che lei le abbia messo le corna.
“Sta grandissima fija de ‘na zoccola! Zoccola tu’ madre… E zoccola te!”
(Anche lui, proprio come i miei superiori, sta naturalmente parlando in slang della banlieue, ma vi assicuro che la mia traduzione fa assolutamente onore allo spessore e alla drammaturgia del dialogo originario.)
“Non è vero!” Si difende lei. “Non ho fatto niente! Ti stai sbagliando! Perché non ti fidi di me?”
“Te lo spiego io perché!”
Il colosso infuriato, un mix ben riuscito tra il gigante buono del miglio verde, The Rock e Puff Daddy (…era il 2002, ancora si faceva chiamare così!), sfila all’improvviso il cellulare dalle mani della ragazza.
Ha tutta l’aria di considerarlo come la prova schiacciante della sua teoria.
Lei, naturalmente, non è d’accordo.
“Ridammelo! Non c’è niente dentro! Non c’è niente…non ho fatto niente!”
Lui inizia a brandire minacciosamente il telefono in aria, accompagnandolo con frasi inequivocabili quali: “Te lo faccio vedere io cosa c’è qui dentro! C’è quella zoccola che non sei altro! Ci siete te e quella specie di bastardo che ti sbatti!”, oppure anche: “Se lo prendo, lo ammazzo di botte…e poi quando è morto ne parliamo, se ho ragione o torto!”
(Non so voi…ma io gli credo. E non solo per la sua presenza scenica.)
Di fronte a cotanta minaccia, lei cambia atteggiamento: la sua tracotanza afro-black-ingioellata e con testa semovente-a-scatti improvvisamente svanisce e lascia il posto a un singhiozzare sommesso ma continuo, intervallato a tratti da mormorii di supplica. “Non ho fatto niente…perché non mi credi? Non c’è niente nel telefono…perché io amo te!”
(Se la tipa sta mentendo, merita un Oscar. O, quantomeno, il plauso di Gigi d’Alessio che finalmente ha trovato una degna interprete nella vita reale del suo apprezzatissimo brano “Non dirgli mai”.
Si, quello… non fate finta di non conoscerlo, ché tanto non ci credo.)
“No, tu non mi ami…tu sei una zoccola!”
Ok, lui non le crede.
Non discuto le basi della sua teoria — in primis perché sto iniziando ad avere una certa fifa e poi perché non conosco i dettagli della faccenda — ma sicuramente non si può dire che le sue argomentazioni siano poi così variegate. Ecco.
All’ennesima rimostranza di lei, all’ennesimo tentativo di fargli capire che non ha fatto niente (e pure lei si applica poco, peró, che cavolo!), lui impazzisce.
Si alza in piedi in tutti i suoi (almeno) 190 cm e (probabilmente) 120kg di muscoli, sempre brandendo il cellulare in mano, ben alto sopra la sua testa, e si produce in un monologo aggressiv-drammatico che Spike Lee avrebbe volentieri preso in considerazione per un film.
Dice che la ama, che lei è la sua vita, che ha fatto tutto per lei, che non farebbe mai nulla per farle del male.
Su quest’ultima affermazione, visto come la sta sovrastando fisicamente e come le agita il cellulare davanti al viso, io avrei qualche dubbio… ma comunque, badando bene ad aumentare la distanza tra me e loro, continuo a seguire la scena.
(…Eh, mo’ vojo sapè er finale, pour l’amour de Dieu!)
Le belle parole del monologo non sembrano aver tranquillizzato la ragazza, anzi. Maggior effetto ha suscitato la postura minacciosa dell’energumeno, che ha spinto la povera figlia a rannicchiarsi contro il sedile quasi in posizione fetale.
Ai miei occhi appare, in una sorta di repentina visione del futuro, già come un mucchietto d’ossa… ma è allora che parte il colpo di scena… è allora che l’orgoglio delle international united black women prende il sopravvento.
La ragazza si alza, lo fronteggia dal basso del suo metro e qualche spiccio (o di due mele o poco più… o ancora, per essere proprio descrittivi, di un cazzo e due barattoli) e lo guarda dritto negli occhi.
“Ma che cazzo dici?” (Oh Signore, e chi se l’aspettava st’uscita?) “Tu non mi ami! Tu non faresti proprio un cazzo di niente per me!”
“Ah no?” Risponde lui, e si direbbe quasi interdetto se non fosse che sta urlando. “Ah noooooo???”
“No!” C’è da dire che lei non è arretrata di un millimetro, nonostante l’impatto fisico dei decibel. “Sei solo un coglione, paranoico e geloso! Sei un testa di cazzo di merda! Vatti a scopare la tua razza!”
(Insulto francese, ahimè intraducibile in dialetto romano, ma che io trovo altamente eloquente e non omettibile.)
Sarà l’imprevista tracotanza della fanciulla, sarà l’insulto giusto al momento giusto, sarà l’umidità nell’aria o che cazzo ne so io… sta di fatto che lui perde le staffe. Di brutto.
“Ah sì, eh? È questo che pensi di me? Allora Te lo devo spiegare io chi sono!”
Maciste a toni scuri brandisce il telefono per l’ultima volta e poi lo scaglia violentemente al suolo, frantumandolo in mille pezzi che si spargono tipo ovunque, anche addosso a me.
Dopodiché, prende ed esce dal vagone.
E meno male, perché se non fosse uscito lui avrei dovuto farlo io… e, nonostante Parigi all’epoca fosse un posto più sicuro di oggi, sapete com’è, a dormire per terra non ci volevo proprio restare.