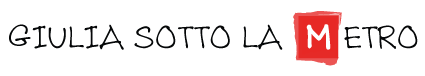Questa è una storia breve, triste e tristemente vera.
Non so che altro dire, se non che — lo giuro — mi è successo realmente.
Ore 19.30 di un afoso giorno di mezz’estate in cui l’umidità mi fa desiderare la morte per stordimento… Un giorno in cui le ferie non sono abbastanza lontane perché io non ci pensi affatto, ma neanche abbastanza vicine perché io inizi ad annusarne l’odore.
Ho iniziato da poco a lavorare per un nuovo programma dalla tematica spiacevole che, me lo sento, non porterà altro che guai e per il quale già sto uscendo troppo tardi dal montaggio: va da sé che il livello del mio umore non è propriamente ai massimi storici e figuratevi che voglia abbia io di entrare in un vagone pieno zeppo di gente sfatta, maleodorante e imbufalita (come me).
D’altronde, però, se non lo faccio a casa non ci arriverò mai e le speranze di migliorare il mio stato psicofisico rimarranno pari a zero.
Quindi, calma, gesso e anima in pace: il convoglio è in arrivo, tocca entrarci.
E così faccio. Solo che, non appena varcata la soglia della esiziale vettura, a stento riesco ad addentrarmi, tanto è stipata di esseri umani di ogni età, sesso, razza, colore, religione e ceto sociale. Mi fermo nei pressi di una fila di sedili senza neppure riuscire ad aggrapparmi al palo più vicino.
(Ah, mi rendo conto solo ora dopo tanti racconti di non aver mai esplicitato un dettaglio più che rilevante: madre natura m’ha fatto diversamente alta — due mele o poco più, come direbbe Cristina d’Avena — perciò o m’attacco ai pali verticali o m’attacco al cazzo, perché ai sostegni orizzontali appesi al soffitto non ci arrivo di diversi centimetri.)
Ora, da una parte è scientificamente confermato che la densità dei corpi solidi contenuti all’interno del vagone è tale per cui gli stessi riescono a mantenere la posizione eretta grazie alla pressione che esercitano l’uno contro l’altro. Dall’altra, però, è empiricamente verificabile anche che detti corpi solidi non si trovino all’interno di un sistema statico; pertanto, al primo scossone a cui la vettura va incontro — a causa di determinate e improvvise curve da rally che si trovano sparse a casaccio tra Spagna e Re di Roma — i corpi perdono istantaneamente la loro condizione di equilibrio e cadono rovinosamente, secondo il secondo e il terzo principio della fatalità romana, ovvero “chi pijo, pijo” e “a chi tocca nun se ‘ngrugna”.
(Per chi fosse interessato, il primo principio recita “ndo cojo, cojo”.)
Nonostante i miei sforzi, a una delle ultime curve prima di arrivare a Furio Camillo… vacillo di brutto.
L’avevo quasi scampata, cazzo.
La vettura piega a sinistra, io cerco di bilanciare il mio baricentro sulla destra, non ci riesco, crollo addosso alla mia vicina di sinistra e le pesto un piede.
La tragedia è che io ho gli stivali, lei i sandali.
La tipa apre la bocca per urlare, ma non lo fa. Mi guarda in cagnesco, compie dei movimenti scomposti con le mani, bestemmia mentalmente tutto il calendario (e lo vedo che lo sta facendo, soltanto non saprei dire se lo fa mentalmente perché capisce che non l’ho fatto apposta o perché è molto devota.)
Complice anche lo sguardo atterrito di una signora seduta davanti a noi che si è gustata la scena dall’inizio, io mi sento una merda: non ho idea di come reagirei al posto suo, vorrei tanto fare qualcosa per farmi perdonare… ma so che non posso. Dunque, ancora prima di rendermene conto, mi sento dire: “Mi dispiace da morire, se vuole mi può pestare il piede anche lei in cambio.”
(E là sì che rischio davvero la vita, mentre la signora seduta sbotta a ridere in maniera fragorosa e genuina.)
“Io non ti ho detto una parola.” Mi risponde la tipa, incazzosa ed evidentemente priva di senso dell’umorismo, mentre io scendo di corsa alla fermata di Furio Camillo che, per una volta, mi è sembrata arrivare prima del previsto.
…Ahò, io ve l’avevo detto subito che era una storia breve e triste.