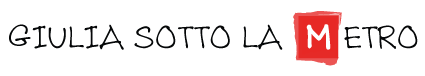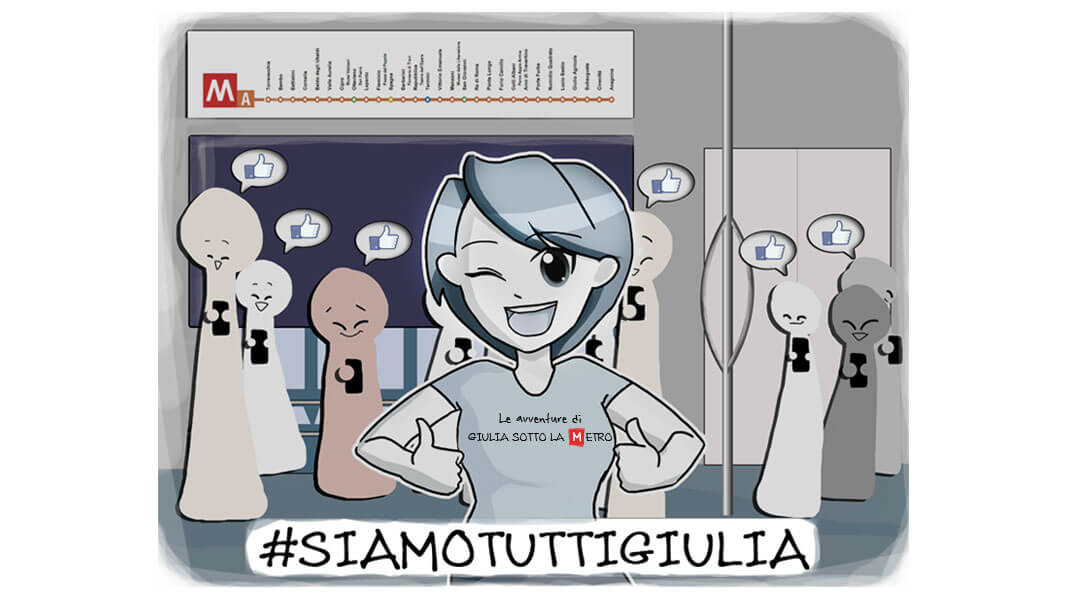Questa strana storia, accaduta in un freddo pomeriggio di gennaio, è una di quelle che per varie ragioni non so bene come raccontare.
In primo luogo, l’arena in cui si svolge è un autobus che non prendo mai, il 590.
Come qualcuno saprà, io sono un mammifero abitudinario e poco disposto alla scoperta di nuovi territori; lontano dalla metro A, dal 628 o dall’87 provo il disagio vibrante di un pesce fuor d’acqua, ma anche – volendo essere un filo meno banali – di una giraffa al polo nord, o ancora – volendo essere sicura che mi comprendano tutti, ma proprio tutti – di un atalantino al San Paolo o di uno juventino al Franchi.
In seconda battuta, poi, c’è da dire che il 590 ha l’inutile caratteristica di passare una sola volta all’ora lungo un percorso pressoché identico a quello della metro A; ciò significa che, volendo dare a Cesare quel che è di Cesare, sarà anche bello vedere la luce del sole durante il tragitto ma se per andare da casa a Ottaviano ci impiego due giorni e mezzo invece che quaranta minuti, tanto vale che mettersi l’anima in pace e prendere la via del sottosuolo.
Infine, trovo doveroso specificare – questa volta più del solito, a mio avviso – che non ho mai visto prima d’ora il protagonista della vicenda, che non l’ho mai più incontrato in giro, che non so assolutamente di cosa accidenti stesse parlando e ancora oggi non sono riuscita a capirlo.
(Ciò, naturalmente, nulla vuole togliere al delirio lisergico della scena che segue.)
Ignara del mio destino, in ogni caso, me ne sto seduta covando forti sospetti nei confronti della linea che mi sta trasportando; all’altezza di Re di Roma – dopo circa un’ora di viaggio nel traffico sfinente che caratterizza la città eterna al calar della sera – smadonno ritmicamente l’intero calendario, nell’attesa di poter finalmente rientrare a casa.
Nei pressi della fermata, il veicolo accosta, apre le porte e lascia salire un tipo tarchiato eppure tendente al flaccido: il suo volto è ricoperto da una peluria rossa, mentre l’abbigliamento total black dai Moon Boot allo zuccotto di lana è quello (Dio solo sa perché!) del campione regionale di discesa su busta della spazzatura a Monte Livata. Nonostante ciò, tiene davanti al volto un cellulare in modalità video-selfie, lo guarda fisso con aria ispirata e parla a voce alta.
Ha tutta l’aria di uno che sta registrando un video.
O peggio, di uno che sta video-chattando.
O peggio ancora, Dio ce ne scampi e liberi… dato il proseguimento della faccenda, di uno che è in diretta su Facebook.
“Ho deciso!” Dice solennemente l’amico pel di carota. “D’ora in avanti, andrò soltanto al Pulcinella perché…”
Con fare navigato, esegue una breve pausa in modo da creare la tensione giusta al momento giusto. “…è l’unico che mi completa!”
Ecco. Tie’, becca.
La signora seduta accanto a me mi guarda. Io le sorrido e sono pronta a scommettere che – grazie alla Sora Lella in miniatura che alberga gratuitamente in ogni cittadino romano degno di questo nome – entrambe stiamo pensando all’unisono le seguenti parole: “Ah… ‘nnamo bbene… ‘nnamo proprio bbene.”
Il ragazzo continua a parlare, mentre controlla di continuo la sua immagine nello schermo del cellulare e scandisce le parole ad un ritmo lento, costante e molto fastidioso.
“Le altre scelte che ho fatto… sono state sempre sbagliate…” L’amico sembra prendere coscienza tra sé e sé di questo determinante momento della sua vita. “Basta centri. Basta circoli. Don Orione, basta. Da oggi c’è solo il Pulcinella… perché il Pulcinella… è l’unico che mi completa.”
La signora e io continuiamo a guardarci, producendo mentalmente illazioni silenziose (e destinate a rimanere tali) su che tipo di struttura possa essere il Pulcinella e sulle ragioni per cui il ragazzo ci si trovi così bene.
Per dovere di cronaca, va detto che la fermata che il 590 effettua nei pressi di Furio Camillo è ingannatrice, in quanto preceduta una ventina di metri prima da quella di altre linee di zona: a volte gli autisti si confondono e si fermano prima, a volte lo fanno volontariamente roprio come in questa occasione. All’improvviso, l’autista ferma il bus davanti alla paletta del 650, spalanca solo le porte anteriori e fa salire ben tre controllori.
Fungo cruento, cupola e gran fumata.
(Cit. Pablo Neruda, e non è neanche la prima volta che mi capita di farlo, a bordo dei mezzi pubblici.)
Ora. Il mio titolo di viaggio obliterato e io siamo totalmente a posto con la coscienza, così come pure – mi sembra – la signora seduta accanto a me. Lo stesso non si può dire, però, del resto dell’equipaggio a bordo, definibile in maniera eufemistica in preda al panico.
“Dobbiamo scendereee… Fateci scendereee… Apra le porte, autista! Subito!”
A occhio, e permettetemi di sottolineare l’ovvio, non dev’essere un caso che l’autista abbia inchiodato alla fermata sbagliata. D’altronde, sono le sue stesse parole a metterlo in chiaro.
“Mi dispiace, signori. Questa non è una fermata della nostra linea, quindi non posso aprire le porte. Potrete scendere più avanti tra circa venti metri.”
(Giusto il tempo necessario perché i controllori possano multare tutti quei furbetti scrocconi che sono a bordo senza biglietto. Non lo dice, ma lo pensiamo tutti, annichiliti come siamo dalla scaltrezza congiunta del personale ATAC e dal loro piano d’azione, efficace e tempestivo a livelli che manco James Bond.)
Il fatto che anche l’amico rossochiomato sia sprovvisto di biglietto in regola non costituisce nessun colpo di scena o twist narrativo; lo obbliga, però, ad abbandonare il video che stava registrando fino a poco fa, a amalgamarsi con la follia dilagante e a essere abbandonato dalla completezza interiore che il Pulcinella sembrava avergli garantito per sempre. L’enunciazione suadente delle sue parole di poc’anzi si trasforma in un urlo scomposto.
“Famme scenne, autistaaa! Subbito!” Col quasi.
(Amico mio, fattene una ragione e per un po’ lasciati completare dal 590, perché per il momento pare proprio che non andrai proprio da nessuna parte.)
In tutta onestà, devo ammettere che il parapiglia in corso è difficile da osservare e di conseguenza da raccontare: gente che corre, gente che si arrampica su specchi che non ci sono, gente che ricorre a nonne defunte e a case incendiate come alle elementari, gente che perde la dignità (o che forse non l’ha mai avuta).
Per motivi a me ignoti, comunque, il nostro eroe sfugge al controllo a tappeto e scende in serenità assieme a me alla benedetta fermata di venti metri dopo.
Inizia a camminare su Via Appia in direzione di Furio Camillo e io, poco distante, lo seguo perché si dà il caso che voglia ancora tornare a casa e che per farlo debba andare da quella parte. Certo, non posso negare che una parte di me sia divorata dall’idea di scoprire cosa sia il Pulcinella (mentre i controllori sconvolgevano il 590 con la loro macarena a sorpresa, ho cercato su Google; purtroppo, non ho trovato nulla), ma credo che dovrò farmene una ragione.
Mentre cammino, infatti, vedo l’amico pel di carota estrarre nuovamente il cellulare e prepararsi per una nuova registrazione.
“Il Pulcinella e’ l’unico che mi completa…” ripete nuovamente, ripristinando l’ammaliante litania che tanto mi aveva colpito qualche minuto prima. “D’ora in poi… solo Pulcinella.”
Ed è lì, che mi tocca girare a destra all’altezza di via Cesare Baronio perché sennò a casa non ci torno più per davvero.
(Tratto da una storia realmente accaduta a Carlo S., lettore di “Giulia sotto la metro”)