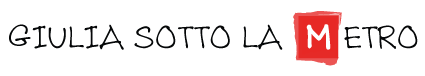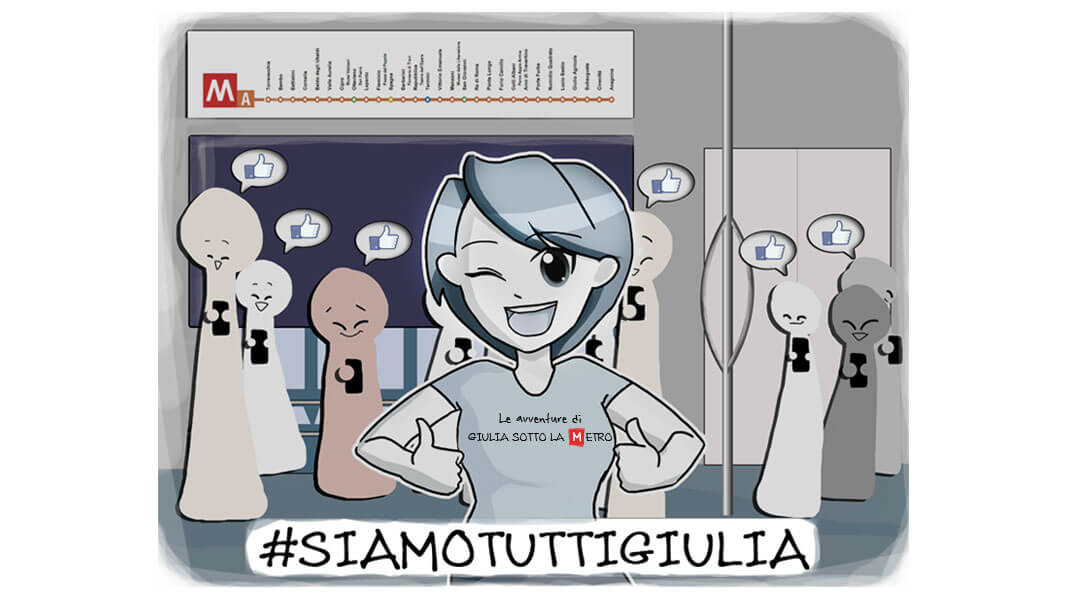Prendo la metro due o tre volte l’anno. Ed è un peccato perché, per un cantastorie come me, la metropolitana di Roma può essere un gigantesco libro da cui trarre ispirazione.
Tempo fa, ho fatto il tragitto Cinecittà ― Barberini. Abbastanza lungo da permettermi di vivere due storie significative in tempi come questi, in cui i concetti di integrazione e umanità non sono poi così di moda. La prima l’ho vista da spettatore esterno, la seconda l’ho vissuta da co-protagonista.
Primo atto.
Di fronte a me, una ragazza e suo figlio. I tratti somatici e l’accento dichiarano apertamente la loro nazionalità straniera. Probabilmente Europa dell’Est.
Entra nel vagone una signora anziana. Si aggrappa disperatamente al primo palo che trova. Sa che quando il treno ripartirà, lo sbalzo per lei sarà impegnativo. La ragazza dell’Est (ottimo titolo per una storia, peccato l’abbiano già preso) si alza in piedi ed offre il suo posto alla signora, spiazzata da cotanta gentilezza. Ancora avvinghiata al palo, spiega alla giovane che non ce la farà mai ad arrivare a quel sedile vuoto senza cadere.
La signorina prontamente le risponde: “Non c’è problema. Ti prendo io“.
Si avvicina, prende la vecchina per il polso e la accompagna a sedersi. Dopodiché, si siede al posto del figlio e si carica il pargolo sulle gambe. Fin qui, tutto sembra portarci al lieto fine. Gentilezza ed educazione che superano le stupide barriere culturali e razziali. Se non che, i minuti successivi diventano surreali. La ragazza è girata da un lato, la signora dall’altro. Le loro espressioni sono tristi. Sembra quasi che abbiano appena litigato. L’anziana continua a guardare in ogni direzione che sia lontano dal volto della giovane straniera. Sembra quasi che il fatto di essersi fatta aiutare da quella ragazza le dia un fastidio incredibile. Alla fermata successiva, si libera un altro posto a sette passi di distanza. La signora fa uno scatto da centometrista e si accaparra la seduta. Poi si gira verso la giovane mamma e sorride. Sorriso corrisposto.
Una domanda però comincia a martellarmi il cervello: si è spostata per permettere a mamma e figlio di stare seduti comodamente, oppure non sopportava di essere accanto a quella straniera e alla prima occasione è fuggita che manco Usain Bolt?
Boh, sarò io che penso sempre male.
Secondo atto.
Mentre mi spremo le meningi sul precedente interrogativo, spunta nel vagone un’altra persona anziana. Un uomo. Molto più coraggioso e schietto della sua coetanea, si presenta davanti a me e al giovine che mi sedeva di fianco e, con lo sguardo languido, ci chiede palesemente di potersi sedere. Ovviamente la nostra reazione è affermativa.
Ci alziamo entrambi, e subito lui esclama: “Eh, addirittura due!”
Dei due cavalieri, decidiamo che quello che può rimettersi a sedere sono io. A quel punto, la svolta della storia. La prova dell’eroe. Il signore attacca bottone. Con me, che sono stato campione olimpionico di misantropia e sociopatia dal 2012 al 2015.
Io non la so fare conversazione con gli sconosciuti. Cioè, di solito faccio il buffone per rompere il ghiaccio e poi da lì è tutto più facile. Ma parlare con una persona anziana e sconosciuta per me è come scalare l’Everest senza bombole.
Il vecchietto chiede il mio nome, la mia età, da dove vengo e dove sto andando. Le classiche domande da viaggio. Una parte del mio cervello comincia a parlare: “Perché dovresti dargli queste informazioni? E’ uno sconosciuto. Inventati qualcosa. Dagli un nome di fantasia. E per l’amor di Dio, non rivelargli dove stai andando.”
Io lo guardo a fasi alterne. Il suo sguardo invece è fisso su di me. Cerca un collegamento visivo, vuole agganciare le mie pupille. Alla fine gli dico il mio vero nome, ma gli nascondo il fatto che stavo andando a fare la prova dell’abito da sposo. Come se fosse una sensibilissima informazione top secret. Qualcosa che la CIA pagherebbe oro per sapere. Gli dico semplicemente che dovevo vedermi con un amico. Poi lui mi racconta la sua storia. E mentre la ascolto, comincio a vergognarmi come un ladro.
Mentre l’adorabile vecchietto si presenta con il nome di Johnny (o almeno questo è quello che ho capito io) e dice di venire dall’Albania, mi racconta il suo tragitto verso la casa del nipote per passare un po’ di prezioso tempo con lui, prima di tornare alla casa-famiglia che lo ospita a Civitavecchia. Io lo guardo negli occhi. E vedo una persona anziana, stanca, con un passato tormentato alle spalle e un’immenso desiderio di contatto umano.
Il colpo di grazia, però, me lo dà quando mi chiede di prendere un caffè con lui a Termini. Cosa cazzo avrebbe potuto farmi? Tirare fuori un coltello? Quelle mani, massacrate da una vita vissuta fino all’osso, non sarebbero riuscite neanche a tenere stretta la presa sul manico. Di cosa dovevo aver paura? Di nulla. Ma il destino beffardo ha voluto che quella mattina fossi veramente in ritardo. La sartoria mi stava già aspettando. Dunque, declino gentilmente l’invito.
Epilogo.
Lui alza le spalle, cercando di nascondere quanto in realtà abbia fatto male quel mio rifiuto. Arrivati a Termini, mi stringe nuovamente la mano, si alza in piedi e sparisce tra la folla aggressiva e nevrotica. Mentre un’ingombrante e rumorosa famiglia francese invade il vagone, il mio sguardo è a terra. Penso al signor Johnny, a quel momento che avrei potuto regalargli. E mi prende lo sconforto, mentre realizzo che quando si vive nella paura, ci si dimentica di essere umani.
Le chiedo scusa, signor Johnny.
Le auguro cento di quei caffè. Con qualcuno che riesca a reggere il peso di quello sguardo sorridente.
Tratto da una storia realmente accaduta a Andrea F., lettore di “Giulia sotto la metro”